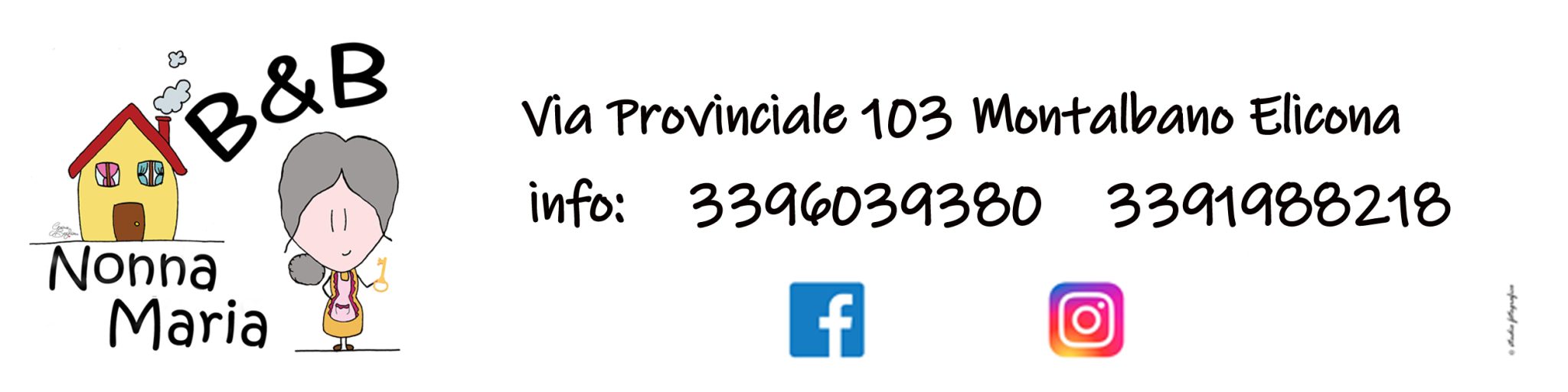Salva articolo
Salva articolodi Emanuele De Francesco
Sebbene l’argomento sembri passare sotto silenzio (anche a causa di una preoccupante regressione della libertà di stampa e della trasparenza), tra pochi giorni saremo chiamati a votare per un referendum abrogativo/modificativo su cinque quesiti, invocati secondo la prevista procedura costituzionale. Ogni cittadino ben informato dovrebbe cogliere questa opportunità per diventare protagonista di scelte di grande importanza che lo riguardano direttamente.
In questa sede, non intendo addentrarmi in descrizioni tecnico-giuridiche o nell’esegesi delle norme che la proposta referendaria mira ad abrogare o modificare: sarebbe superfluo. L’obiettivo del mio intervento, anche in forza della mia esperienza in materia come avvocato giuslavorista, è fornire elementi minimi di conoscenza utili per esercitare con consapevolezza il voto referendario dell’8 e del 9 giugno 2025. Si tratta, infatti, di un tema di forte impatto su alcuni diritti fondamentali dei lavoratori italiani. È necessario ricordare che l’ordinamento giuridico italiano vanta, in materia di tutela e difesa del lavoro e dei lavoratori, una legislazione tra le più moderne e complete al mondo, a partire dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso. Una pietra miliare di tale legislazione è la Legge 300 del 1970, altrimenti nota come “Statuto dei Lavoratori”. Questa legge, al pari di altre che disciplinano la materia (come la legge 604/1966), rappresenta il risultato di una lunga e preziosa elaborazione di dottrina e giurisprudenza, da sempre impegnate ad attenuare l’enorme disparità di forze tra datori di lavoro e lavoratori, che fin dalla nascita dell’era industriale ha sempre caratterizzato il contratto di lavoro. Si parla di metus del lavoratore, intendendo con ciò il vincolo di soggezione che il datore di lavoro tende a esercitare nei confronti del lavoratore subordinato, al quale spesso si richiede l’accettazione di condizioni di lavoro con scarse tutele sia economiche che di sicurezza sul luogo di lavoro, pena la minaccia di conseguenze “sanzionatorie” fino al licenziamento. Il lavoratore era, ed è assai spesso tutt’oggi, costretto a sottostare a questa costante minaccia che pende su di lui come una spada di Damocle. Il licenziamento, come è noto, specie in economie depresse come quelle del Sud Italia, rappresenta per intere famiglie la privazione delle minime risorse di sopravvivenza, necessarie anche per soddisfare i bisogni primari.
La tentazione di innestare modelli normativi in materia di diritto del lavoro derivati dal diritto anglosassone, e in particolare da quello statunitense, è sempre stata alla base delle ambizioni delle parti datoriali, siano essi semplici imprenditori o industriali, ma non coglie nel segno. Ciò sia per l’enorme differenza culturale che caratterizza la società europea e italiana in particolare rispetto a quella statunitense, sia, soprattutto, per la differenza tra le due economie, che non sono soltanto diverse in termini di ricchezza, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle rispettive dinamiche e del differente contesto. Chi perde il lavoro in Sicilia si troverà ad affrontare enormi difficoltà nel trovarne un altro, diversamente dal lavoratore americano che, per mentalità e per caratteristiche di quel mercato che risulta essere assai più dinamico. E poco importa se oggi, per fortuna (anche in tal senso la nostra è una legislazione evoluta ed efficace), esistono tutele statali di contrasto con un sistema di welfare lungimirante e capillare (anche se si può sempre fare di meglio). Ricordiamo, infatti, che quando un datore di lavoro, per proprio tornaconto personale, per delirio di potere o semplicemente per aumentare la marginalità di guadagno, attua un sopruso nei confronti di un lavoratore (ad esempio licenziandolo ingiustamente o facendolo ammalare), il costo di “protezione” viene immediatamente ribaltato su tutti noi cittadini.
Tale premessa ritengo si rendesse necessaria per meglio focalizzare il tema della nostra riflessione. È proprio per contrastare tali fenomeni di sfruttamento e mancato rispetto delle tutele, e in generale l’evidente disparità di forze tra datore di lavoro e lavoratore dipendente nelle piccole realtà aziendali, come nella grande industria (dove però vige una legislazione integrativa ancora più specifica, specie in materia di licenziamenti collettivi), che venne pensato e introdotto il tanto vituperato articolo 18 della Legge 300/1970. Tale norma, prima del rivoluzionario e demolitivo intervento normativo della Legge “Fornero” del 2012 e poi del Jobs Act (dal 2015), era destinata a operare in tutte le realtà produttive che registravano nel proprio organico (semplifico per esigenze di contesto) più di 15 dipendenti o 60 se dislocati in differenti unità produttive nel territorio nazionale. Semplificando ulteriormente, prevedeva che, tutte le volte in cui il licenziamento risultava essere comminato senza alcuna giusta causa o giustificato motivo soggettivo od oggettivo (quindi illegittimo o nullo), il lavoratore subordinato ingiustamente licenziato avrebbe vantato il diritto, di norma a seguito dell’accertamento giudiziale, alla reintegrazione “effettiva” nel proprio posto di lavoro. È quella che la giurisprudenza della Cassazione chiama “tutela reale forte” e aveva l’effetto di consentire al lavoratore, vittima di ingiusto licenziamento, di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, beneficiando della corrispondente retribuzione. Costringeva, inoltre, il datore di lavoro a subirne adeguate ripercussioni economiche (vero e incisivo deterrente alla reiterazione di tali abusi), mediante il riconoscimento di un risarcimento del danno corrispondente a tutte le retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data del licenziamento ingiusto fino all’effettiva reintegra. Accanto a tale tutela si poneva invece quella cosiddetta “obbligatoria”, vigente nelle aziende più piccole (sotto i 15 dipendenti), che a fronte di un licenziamento illegittimo prevedeva soltanto un risarcimento del danno di norma di natura indennitaria (quindi prestabilito nell’entità e nella debenza) ma di poco valore e quindi di scarsa efficacia dissuasiva. Ecco, dal 2012 si è demolita quella norma, l’articolo 18, rendendola assai più simile a quelle previste dalla legge 604/1966, più magnanime e favorevoli al datore di lavoro. E il Jobs Act del 2015 (introdotto da Renzi), seppure con qualche modifica, in alcuni punti a favore del lavoratore e in altri del datore di lavoro ha sostanzialmente mantenuto la portata demolitrice della legge Fornero, creando perfino più confusione e introducendo una normazione complessa, burocratica, cavillosa e non chiara, restituendo all’Italia un sistema complessivamente assai più sfavorevole e meno efficace per la tutela del lavoro subordinato. Tant’è vero che, con diversi interventi (il primo nel 2018, l’ultimo nel 2024), la Corte Costituzionale si è vista costretta a intervenire, dichiarando in più punti incostituzionali alcune norme del Jobs Act del 2015.
Una corretta informazione è quindi doverosa. Si tratta di decidere come sanzionare una condotta “illegittima” del datore di lavoro: se con la reintegrazione o con una quantità di denaro sempre largamente insufficiente sia a fare da deterrente, sia a dare un effettivo ristoro al lavoratore che rimarrà senza retribuzione.
Altro quesito, invece, attiene alla materia, attualissima e di larghissima diffusione, dei contratti a termine, ovvero i contratti a tempo determinato. È noto a tutti come questi contratti rappresentino ormai la forma più frequente di contratto di lavoro subordinato. Ma se è vero che garantiscono al datore di lavoro una grande flessibilità, per altro verso hanno contribuito a costruire una società di giovani lavoratori precari, con pesanti ripercussioni sul benessere delle nuove generazioni. Costrette a farsi mantenere dai genitori fino ad età adulta e fortemente ostacolate nella costruzione del loro progetto di vita e persino nella formazione di una famiglia autonoma (quella ambita dalla nostra Presidente del Consiglio), tanto da apparire, secondo molte statistiche sociologiche, una delle generazioni più infelici dal secondo dopoguerra. Ed infatti, per i contratti a termine, già con il D.Lgs. 81/2015 si era consentito ai datori di lavoro di accedervi senza particolari motivazioni e nel 2018 è stato del tutto eliminato dalla legislazione l’obbligo di motivazione (entro certi limit), consentendo ai datori di lavoro di accedere a tale forma di rapporto di lavoro (che offre molte minori garanzie per il lavoratore e che dovrebbe rappresentare un’eccezione rispetto al lavoro a tempo indeterminato) per così dire ad libitum e quindi a propria discrezione e scelta. Infine, uno dei quesiti chiede di abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale del committente nei confronti dei diritti economici del dipendente dell’appaltatore. Questa rappresenta invece una garanzia fondamentale in caso di lavori concessi in appalto, perché laddove i giusti diritti del lavoratore dipendente dell’appaltatore non venissero riconosciuti e pagati da quest’ultimo, di tali inadempienze deve farsi carico (con i limiti previsti dalla legge che non occorre in questa sede spiegare) il committente dell’appalto, rafforzando la garanzia per il lavoratore impiegato nell’appalto di poter in ogni caso vedersi retribuite le proprie spettanze. Per completezza, l’ultimo quesito riguarda la riduzione da 10 a 5 anni del tempo necessario per gli stranieri per poter avviare la richiesta di cittadinanza. Anche se non è del tutto attinente, il quesito, anzi il tema, è indirettamente collegato con il mondo del lavoro, poiché il lavoratore straniero in attesa di poter ottenere la cittadinanza è spesso soggetto a forme di ricatto e di sfruttamento maggiori rispetto al lavoratore cittadino. Anche se ritengo che la sinistra avrebbe potuto e dovuto rimandare questo quesito ad altra tornata, da riservare al più complesso e delicato tema del diritto dell’immigrazione. Concludendo, abrogare quelle norme di cui abbiamo discusso, dicendo “SI” in sede referendaria, aumenterà notevolmente le tutele dei lavoratori subordinati, ristabilendo un giusto equilibrio nei rapporti di forza contrattuale tra datori di lavoro e lavoratori. Mettete da parte l’ideologia e riflettete: se nella vostra famiglia ci sono madri, padri, figli, parenti lavoratori subordinati, dovreste votare per l’abrogazione di quelle norme (SI); altrimenti, se siete una privilegiata famiglia di imprenditori, specie se tendenzialmente scorretti, dovreste votare (NO). Buona democrazia a tutti!