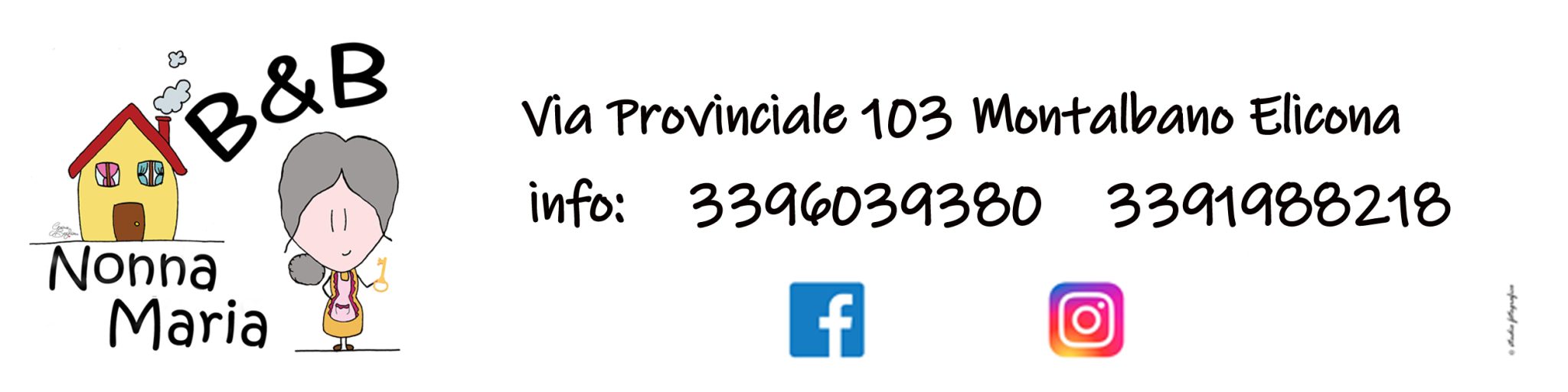Salva articolo
Salva articolodi Coniglione Monisteri Giuseppe
Giovedì 23 agosto 1928, le vie del centro di Montalbano Elicona sono addobbate con drappi, ghirlande e bandiere tricolori e nel Piazzale Umberto I° è adunata la cittadinanza. In questa giornata, che cade nel periodo di feste cittadine con fiera di bestiame e mercato di generi diversi che hanno luogo dal 22 al 24 di agosto di ogni anno, si svolge la cerimonia solenne di inaugurazione del Monumento ai Caduti della Grande Guerra. L’evento è presieduto dal Podestà e sono schierate le rappresentanze dei vari sodalizi e organizzazioni locali, inoltre, a sottolinearne il carattere straordinario, presenziano alla cerimonia Mons. Angelo Paino e il Commendatore Agostino Guerresi, rispettivamente Arcivescovo e Prefetto di Messina. Nel viaggio alla riscoperta del monumento ai caduti di Montalbano Elicona, uno dei percorsi possibili, oltre a quello che ho proposto in un precedente articolo, è quello di puntare i riflettori sul contesto in cui fu concepito e realizzato il progetto commemorativo, seguirne l’evoluzione semantica e proporre una narrazione alternativa agli stereotipi celebrativi contingenti . A questo proposito l’immagine di Montalbano di quegli anni ci proviene dalla “XX edizione de “La Trinacria” Annuario di Sicilia – Guida Amministrativa Commerciale – Professionale di tutta l’Isola – del 1928 e dai dati demografici dei censimenti dell’epoca. Nella descrizione de La Trinacria (in continuità con le precedenti edizioni e sulla base degli aggiornamenti forniti dal corrispondente locale che era il Podestà) il comune di Montalbano Elicona nel 1928 ha raggiunto l’apice della crescita demografica (7460 residenti) ed “è un paese molto progredito, vi sono piazze e strade ampie, luce elettrica e acqua potabile abbondante con fornitura ai privati. In estate è frequentata da villeggianti ed escursionisti date le eccellenti condizioni climatiche e la speciale ubicazione dell’abitato, ed è consigliato come soggiorno per convalescenti e ammalati delle vie respiratorie”. Il comune possiede un Teatro ed è presente una Ricevitoria Postale e telegrafica. Un servizio automobilistico con due corse giornaliere collega Montalbano con la stazione di Castroreale – Novara Furnari sulla linea Messina-Palermo. Nel comune c’è una scuola elementare completa con corso integrativo, una scuola di lavoro maschile (fabbri e falegnami) e una scuola di lavoro femminile (lavori donneschi). La Trinacria a proposito delle attività commerciali e imprese, segnalava anche la presenza di alberghi, assicuratori, calzolerie, ebanisti, elettricisti, fabbri e meccanici, legatori, orefici, orologiai, pastifici, segherie meccaniche, assicuratori e altre attività efferenti il campo agroalimentare. Inoltre elencava i professionisti che vi esercitavano le proprie professioni: 1 agronomo, 12 avvocati, 2 farmacisti, 3 levatrici, 6 medici chirurghi, 2 notai e 1 perito. La lusinghiera descrizione da parte dell’Annuario, trovava conferma nei dati demografici dei censimenti dell’epoca che però registravano dal 1921 al 1936 sia il massimo popolamento (nel 1921 erano stati rilevati 7383 residenti) sia il progressivo spopolamento (nel 1931 la popolazione era scesa a 6189 abitanti), prodromico della crisi demografica tutt’ora in atto. La tendenza di crescita si registrava anche riguardo la popolazione alfabetizzata che risultava in linea con la media regionale. Ovviamente in quel periodo Montalbano Elicona, come tutto il resto della nazione, era soggetto alla pervasività del regime fascista che influenzava la vita della comunità. E difatti il Comune di Montalbano Elicona oltre al Podestà, Restifa cav. rag. Gino, aveva nelle sue articolazioni pubbliche anche una unita’ della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale (MVSN) comandata dal Capo Manipolo Pagano Giuseppe, ed erano attive varie organizzazioni e sodalizi controllati dal regime: la Sezione Fascisti, quella dei Combattenti e quella dei Mutilati, una Centuria della Opera Nazionale Balilla (balilla, piccole fasciste, avanguardia giovanile fascista), e varie rappresentanze dei sindacati fascisti. Al contempo non mancavano segni di non adesione e avversione al regime, sia tra la cittadinanza sia all’interno dei circoli e delle società locali. Nel 1924, anno in cui si tennero le elezioni politiche che assegnarono la maggioranza al Partito Nazionale Fascista (PNF), Montalbano era stato teatro di manifestazioni e di disordini in cui si erano registrati scontri tra fascisti e avversari politici che avevano provocato vittime (Faranda Barbaro Vincenzo) e dunque generato profondi risentimenti nella popolazione. Un’altra caso emblematico era quello della Società Agricola-Operaia, fondata da piccoli proprietari, mezzadri e lavoratori comuni nel 1889, che fino al 1929 aveva cercato di mantenersi politicamente neutrale (afascista) tanto che per il Prefetto Guerresi la maggior parte dei suoi membri erano politicamente apatici, cioè usavano la società per fini personali e utilitaristici, e raramente prendevano iniziative in supporto al fascismo. Tuttavia alla sua chiusura nel febbraio 1929 la società vide molti dei suoi membri entrare nelle organizzazioni fasciste (37 nel PNF, 7 nella milizia, 50 nel Opera Nazionale Dopolavoro, 12 nell’unione di commercio, 1 divenne membro della direzione cittadina del fascio). E comunque nel novembre 1931, quando il sodalizio riaprirà come dopolavoro con il beneplacito del regime, il Commissario Politico locale Occhino F., in una relazione inviata al Prefetto riferirà che il presidente del sodalizio, Pantano Giuseppe, e un centinaio di lavoratori agricoli avevano dichiarato la loro non adesione al PNF e di non essere disponibili a difendere in alcun modo la rivoluzione fascista. Inoltre, non è da escludere che qualche forma di dissenso provenisse da ex militanti del soppresso partito Democrazia Sociale che a Montalbano aveva una influente personalità (Avv. Minissale) che nel passato aveva concorso all’affermazione del partito e nel marzo del 1925 aveva aderito al 2° Congresso Nazionale del Partito convocato dai Domesociali avventiniani con lo scopo di “considerare la linea di opposizione al fascismo, di contemplare l’unione con altri partiti a fondo democratico, e di precisare il pensiero politico della Democrazia Sociale sul momento storico che l’Italia traversava”. Se questo era il contesto locale in cui si consolidò il progetto del monumento e in cui si definirono le dinamiche che lo misero sotto il patrocinio del regime fascista, l’azione di controllo venne a concretizzarsi sia nella scelta dell’appaltatore incaricato di realizzarlo coerentemente ai repertori simbolici del regime, che aveva imposto il culto dei caduti nella prospettiva di una pedagogia politica dell’esaltazione del sacrificio, dell’obbedienza e dell’eroismo, sia attraverso le autorità chiamate a darne ufficialità presenziando alla sua inaugurazione. Ciò emerge chiaramente dalle iscrizioni incise sui prospetti laterali del monumento che indicano l’anno “VI” dell’era fascista (ovvero 29 ottobre 1927 – 28 ottobre 1928), il nome dell’autore (G. CIOCCHETTI), la data di collocazione (maggio 1928), dal fascio littorio scolpito nell’ovale posto sul frontale del basamento ( poi rimosso) e dall’aggettivo “prodi” iscritto nella lapide di dedica. Il Cav. CIOCCHETTI, che realizzo l’opera, faceva parte di una piccola ma fruttuosa pattuglia di imprenditori dell’“industria funeraria” specializzata in monumenti ai caduti e annoverava un’assidua frequentazione fascista. Si era distinto sia per il discreto successo avuto dai suoi monumenti in vari comuni del sud Italia negli anni 20 e 30, sia per le varie sculture di regime che realizzò per la comunità americana di New York e fu autore del corpo centrale e dei due in bassorilievi scenografici laterali della Tribuna Reale in via dei Trionfi allestita in occasione della visita a Roma di Hitler nel 1938. Nel 1933 costrinse i propri dipendenti ad aderire al PNF. Alla cerimonia d’inaugurazione, come già accennato, a conferma della consolidata tradizione religiosa della commemorazione funebre (condivisa in chiave laica dal regime), parteciparono le massime autorità religiose e governative della Provincia di Messina ovvero l’Arcivescovo Paino, che officiò la benedizione, e il Prefetto Guerresi, due figure di alto profilo nella compagine fascista. Infatti Mons. Paino, capo della arcidiocesi di Messina, che si era distinto per il suo attivismo per la ricostruzione del patrimonio ecclesiastico distrutto dal terremoto del 1908, nutrì forti simpatie per il fascismo e Mussolini, di cui divenne amico intimo ottenendo da lui molti benefici per la diocesi. Nonostante ciò mantenne la sua totale fedeltà al Papa quando Mussolini tentò nel 1931 di creare una Chiesa parallela e filofascista, Nel 1938 però rimosse dagli organismi diocesani quanti non erano iscritti al PNF. Così pure il Comm. Agostino Guerresi, Prefetto di Messina dal 1928 al 1930, che era stato Legionario fiumano, brevettato Marcia su Roma, squadrista e luogotenente della MVSN. Aveva ricoperto varie posizioni di vertice del PNF e del Ministero dell’Interno fino ad essere nominato Prefetto nel 1923 e Senatore del Regno nel 1939. Fu uno dei primi Prefetti Politici che ebbero l’apprezzamento di Mussolini che lo cito’ nel discorso dell’”Ascensione” nel maggio 1927. Fascista irriducibile, aderirà in seguito alla Repubblica Sociale italiana. In conclusione, poiché i fini che la storia realizza non sono quelli che gli individui o le comunità si propongono, ma piuttosto la risultante della combinazione di varie condizioni oggettive, il monumento dopo la caduta del regime, epurato dalla simbologia fascista, conservò il valore storico e commemorativo riconosciuto dalle celebrazioni del 4 novembre che la neo Repubblica Italiana dichiarò “Giornata dell’Unità Nazionale” e successivamente anche “delle Forze Armate”. Coerentemente a questo nuovo spirito interpretativo il monumento, in cui il gruppo scultoreo è un esempio di arte dedicata alla guerra che non rievoca azioni militari, nel corso degli anni è stato oggetto di aggiornamenti che ne hanno estesa la sfera semantica ( l’aggiunta, nel 1998, di una lapide commemorativa del Brig. Di Stefano caduto in una azione contro il banditismo nel 1951, e negli anni 2000, di una lapide con nomi dei caduti nel 2°conflitto mondiale). Il riconoscimento della valenza storica e dell’importanza civica che il monumento riveste nell’ambito cittadino è stato confermato nel 2021 con i lavori di restauro, curati da Montalbano Notizie in collaborazione con la cittadinanza e l’amministrazione comunale, che hanno restituito dignità e lustro ad una realtà che dal 1928 accompagna la comunità montalbanese. Ogni anno in occasione della ricorrenza del 4 novembre, viene svolta la tradizionale cerimonia di deposizione della corona al monumento alla presenza dell’autorità locali e il coinvolgimento delle scolaresche locali.